
Docente di Sociologia Generale e di Sociologia dei Processi Culturali
Università di Verona

| (Foto di Lodovico Antonini) | |
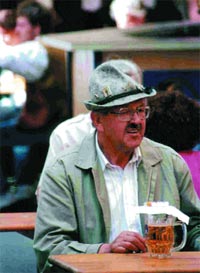 In
una nostra conversazione precedente, mi ero brevemente occupato dell'aumento
del consumo di alcol tra i giovani osservabile da qualche anno a questa
parte, e di come fosse soprattutto tra le giovani donne l'incremento più
eclatante. Come dicevo, varie possono essere le motivazioni, da quelle
sociali a quelle individuali, ed i nuovi ruoli pubblici ottenuti dalle
donne, le espongono certamente a tensioni e frustrazioni per loro nuove,
con un passaggio dall'alcolismo della casalinga all'alcolismo della giovane
emancipata. La nascita, anche tra le donne, di una vera e propria cultura
dell'alcol, che prevede consumi che si distaccano sempre di più
dal cibo, e che si orientano sempre di più secondo la cultura dello
sballo e del bere per ubriacarsi, colora di ulteriore preoccupazione questo
scenario. Va però detto, che la costruzione di una determinata
cultura dei consumi non avviene unicamente in base a fenomeni diretti,
nella nostra società vi sono potentissimi strumenti mediatici che
possono pesantemente influire nella costruzione e nella diffusione di
determinate culture dei consumi. Lo dimostra, tanto per fare un esempio,
l'inarrestabile incremento del consumo di birra, seppur all'interno di
un progressivo calo dei consumi generali di alcol, ed in particolare di
vino, che è sicuramente stato influenzato anche dalle massicce
campagne pubblicitarie, dirette e indirette, che hanno collegato la birra
alla notte, alla musica ed al gruppo di amici, offrendo i giovani un modello
di rituale che legava e “propiziava” una serie di desiderabili
rapporti sociali e gratificazioni all'uso ed al consumo della birra. L'istituto
superiore di sanità ha condotto uno studio che ha monitorato, nell'arco
di un anno, dal 2000 al 2001, la programmazione delle tre reti pubbliche
e delle tre reti commerciali, in relazione alla frequenza ed alla modalità
di presentazione del consumo di alcol durante i programmi messi in onda,
soprattutto film, telefilm e fiction. Dallo studio emerge che il consumo
di alcol è presente sullo schermo con una frequenza di circa 13
minuti (per il fumo, benché ampiamente demonizzato, siamo ad un
atto di consumo ogni 26 minuti che, a mio parere, non è comunque
poco). Diciamo subito che non ci sono particolari differenze tra le reti
monitorate, ma non è questo il punto, è sicuramente molto
più importante che i personaggi che compiono questi atti di consumo
sono soprattutto personaggi di tipo positivo, che la sceneggiatura tratteggia
in modo che risultino simpatici allo spettatore, e che il contesto in
cui il consumo avviene è comunque di piacere convivialità,
che ispira benessere e calore. Per quanto riguarda i generi, sono soprattutto
i film per la televisione e le fiction a presentare le più alte
frequenze rispetto al resto della programmazione. La relazione tra alcol
e convivialità è quindi fortemente sottolineata dai media,
rappresentando il contesto di più della metà degli atti
di consumo rilevati, a seguire, l'alcol si associa a momenti di concentrazione,
ansia e depressione. La sua connotazione positiva è quindi presente
in più dei due terzi degli eventi che sono stati esaminati dall'indagine.
Tanto per fare un parallelo, il fumo risultava associato soprattutto alla
concentrazione, all'attesa ed alla convivialità, ma con una distribuzione
meno sbilanciata a favore di quest'ultima rispetto all'alcol. Anche rispetto
alla connotazione del personaggio che eseguiva il consumo, come abbiamo
detto, più della metà delle situazioni considerate identificava
una personalità ampiamente positiva, mentre, ad esempio per il
fumo, il bilancio tra i personaggi positivi e negativi era quasi in equilibrio.
Questo significa che nell'universo immaginario proposto quotidianamente
dalla televisione, se il fumatore è una figura a volte positiva
ed a volte negativa, chi consuma alcol è una figura soprattutto
positiva. Un risultato certamente notevole se teniamo presente che è
stato ricavato dall'osservazione di prodotti televisivi che non erano
espressamente orientati alla pubblicità, e che a questi dati dobbiamo
aggiungere quelli relativi alla pubblicità diretta che, mentre
ha visto la scomparsa del fumo, continua a presentare gli alcolici come
una qualsiasi altra merce e, naturalmente, nelle pubblicità i soggetti
che consumano la merce pubblicizzata non possono che essere positivi,
e nelle pubblicità degli alcolici, ma anche in larga parte delle
altre, l'aspetto della convivialità e della intensa relazionalità
è fortemente sottolineato. Ad onta dei trend statistici, più
del 70% di questi bevitori è un maschio, e solo il 25-30 percento
è una femmina. Un'altra notazione poco rassicurante che emerge
dallo studio dell'istituto superiore di sanità, è che la
distribuzione, nel palinsesto, dei programmi in cui il consumo di alcolici
è alto, non presenta particolare attenzione per le fasce orarie
in cui è presumibile che tra gli spettatori siano maggiormente
presenti giovani e bambini. I luoghi di consumo dell'alcol sono soprattutto
i locali pubblici ed in secondo luogo le case, bassissima ogni altra ambientazione.
Il contesto, quindi, da un lato si associa con la convivialità,
e dall'altro si presenta come estremamente rassicurante, comunicando così,
indirettamente, un'immagine positiva e sicuramente non pericolosa dell'alcol
che, del resto, rispecchia fedelmente l'opinione comune. Per la grandissima
maggioranza degli italiani, bere uno o due bicchieri di vino o birra a
pasto è una cosa del tutto normale (indagine Doxa), ubriacarsi
ogni tanto non è grave purché non diventi un'abitudine,
e le bevande alcoliche in piccole quantità non danneggiano la salute,
questo anche se la quasi maggioranza pensa anche che bere molto equivalga
a drogarsi. Del resto, in una cultura in cui il consumo del
In
una nostra conversazione precedente, mi ero brevemente occupato dell'aumento
del consumo di alcol tra i giovani osservabile da qualche anno a questa
parte, e di come fosse soprattutto tra le giovani donne l'incremento più
eclatante. Come dicevo, varie possono essere le motivazioni, da quelle
sociali a quelle individuali, ed i nuovi ruoli pubblici ottenuti dalle
donne, le espongono certamente a tensioni e frustrazioni per loro nuove,
con un passaggio dall'alcolismo della casalinga all'alcolismo della giovane
emancipata. La nascita, anche tra le donne, di una vera e propria cultura
dell'alcol, che prevede consumi che si distaccano sempre di più
dal cibo, e che si orientano sempre di più secondo la cultura dello
sballo e del bere per ubriacarsi, colora di ulteriore preoccupazione questo
scenario. Va però detto, che la costruzione di una determinata
cultura dei consumi non avviene unicamente in base a fenomeni diretti,
nella nostra società vi sono potentissimi strumenti mediatici che
possono pesantemente influire nella costruzione e nella diffusione di
determinate culture dei consumi. Lo dimostra, tanto per fare un esempio,
l'inarrestabile incremento del consumo di birra, seppur all'interno di
un progressivo calo dei consumi generali di alcol, ed in particolare di
vino, che è sicuramente stato influenzato anche dalle massicce
campagne pubblicitarie, dirette e indirette, che hanno collegato la birra
alla notte, alla musica ed al gruppo di amici, offrendo i giovani un modello
di rituale che legava e “propiziava” una serie di desiderabili
rapporti sociali e gratificazioni all'uso ed al consumo della birra. L'istituto
superiore di sanità ha condotto uno studio che ha monitorato, nell'arco
di un anno, dal 2000 al 2001, la programmazione delle tre reti pubbliche
e delle tre reti commerciali, in relazione alla frequenza ed alla modalità
di presentazione del consumo di alcol durante i programmi messi in onda,
soprattutto film, telefilm e fiction. Dallo studio emerge che il consumo
di alcol è presente sullo schermo con una frequenza di circa 13
minuti (per il fumo, benché ampiamente demonizzato, siamo ad un
atto di consumo ogni 26 minuti che, a mio parere, non è comunque
poco). Diciamo subito che non ci sono particolari differenze tra le reti
monitorate, ma non è questo il punto, è sicuramente molto
più importante che i personaggi che compiono questi atti di consumo
sono soprattutto personaggi di tipo positivo, che la sceneggiatura tratteggia
in modo che risultino simpatici allo spettatore, e che il contesto in
cui il consumo avviene è comunque di piacere convivialità,
che ispira benessere e calore. Per quanto riguarda i generi, sono soprattutto
i film per la televisione e le fiction a presentare le più alte
frequenze rispetto al resto della programmazione. La relazione tra alcol
e convivialità è quindi fortemente sottolineata dai media,
rappresentando il contesto di più della metà degli atti
di consumo rilevati, a seguire, l'alcol si associa a momenti di concentrazione,
ansia e depressione. La sua connotazione positiva è quindi presente
in più dei due terzi degli eventi che sono stati esaminati dall'indagine.
Tanto per fare un parallelo, il fumo risultava associato soprattutto alla
concentrazione, all'attesa ed alla convivialità, ma con una distribuzione
meno sbilanciata a favore di quest'ultima rispetto all'alcol. Anche rispetto
alla connotazione del personaggio che eseguiva il consumo, come abbiamo
detto, più della metà delle situazioni considerate identificava
una personalità ampiamente positiva, mentre, ad esempio per il
fumo, il bilancio tra i personaggi positivi e negativi era quasi in equilibrio.
Questo significa che nell'universo immaginario proposto quotidianamente
dalla televisione, se il fumatore è una figura a volte positiva
ed a volte negativa, chi consuma alcol è una figura soprattutto
positiva. Un risultato certamente notevole se teniamo presente che è
stato ricavato dall'osservazione di prodotti televisivi che non erano
espressamente orientati alla pubblicità, e che a questi dati dobbiamo
aggiungere quelli relativi alla pubblicità diretta che, mentre
ha visto la scomparsa del fumo, continua a presentare gli alcolici come
una qualsiasi altra merce e, naturalmente, nelle pubblicità i soggetti
che consumano la merce pubblicizzata non possono che essere positivi,
e nelle pubblicità degli alcolici, ma anche in larga parte delle
altre, l'aspetto della convivialità e della intensa relazionalità
è fortemente sottolineato. Ad onta dei trend statistici, più
del 70% di questi bevitori è un maschio, e solo il 25-30 percento
è una femmina. Un'altra notazione poco rassicurante che emerge
dallo studio dell'istituto superiore di sanità, è che la
distribuzione, nel palinsesto, dei programmi in cui il consumo di alcolici
è alto, non presenta particolare attenzione per le fasce orarie
in cui è presumibile che tra gli spettatori siano maggiormente
presenti giovani e bambini. I luoghi di consumo dell'alcol sono soprattutto
i locali pubblici ed in secondo luogo le case, bassissima ogni altra ambientazione.
Il contesto, quindi, da un lato si associa con la convivialità,
e dall'altro si presenta come estremamente rassicurante, comunicando così,
indirettamente, un'immagine positiva e sicuramente non pericolosa dell'alcol
che, del resto, rispecchia fedelmente l'opinione comune. Per la grandissima
maggioranza degli italiani, bere uno o due bicchieri di vino o birra a
pasto è una cosa del tutto normale (indagine Doxa), ubriacarsi
ogni tanto non è grave purché non diventi un'abitudine,
e le bevande alcoliche in piccole quantità non danneggiano la salute,
questo anche se la quasi maggioranza pensa anche che bere molto equivalga
a drogarsi. Del resto, in una cultura in cui il consumo del vino è così profondamente radicato come nella nostra, non
ci si può certo aspettare che l'alcol sia visto come un pericolo
assoluto, il problema può iniziare a subentrare quando dal consumo
“tradizionale” di vino durante i pasti, si inizi a distaccarsi
un consumo autonomo degli alcolici. Questi, una volta svincolati dalle
ritualità del pasto, possono innestare rituali e spazi autonomi,
in cui altre modalità ed altri significati possono insinuarsi nel
loro consumo, aumentando i rischi in misura proporzionale proprio a quella
familiarità, che la nostra cultura ha con il consumo di alcol e
con una sua immagine sostanzialmente positiva o comunque non pericolosa.
Lo spostamento dalla ritualità del pasto a rituali autonomi, e
dal vino associato all'alimentazione ad altri tipi di alcolici associati
al tempo libero, una volta che si innesti in una cultura come la nostra,
in cui l'alcol non è di per sé un pericolo (come, pian piano,
lo sta invece diventando il fumo), può effettivamente produrre
dei comportamenti estremamente rischiosi. È quello che, a quanto
pare, sta accadendo nei gruppi di giovani, ed in particolare di giovani
donne, in cui, a fronte di una lenta e progressiva diminuzione generale,
il consumo di alcol sta aumentando velocemente, ed aumenta secondo rituali
che lo distaccano del cibo, lo collegano alla convivialità ma anche
alla cultura dello sballo, come abbiamo commentato in una precedente conversazione
su questo tema. E questo, a parte i rischi per l'immediato di una tendenza
all'assunzione di alcol fino a perdere il controllo di se stessi, porterà
senz'altro danni alla salute nella seconda metà della vita, ma,
se ben ricordo, a vent'anni faticavo a pensare a quando ne avrei avuto
trenta, figuriamoci oltre; e poi sorge una riflessione decisamente politically
uncorrect: non sarà che per campare, in questo mondo, qualche aiutino
è proprio indispensabile? •
vino è così profondamente radicato come nella nostra, non
ci si può certo aspettare che l'alcol sia visto come un pericolo
assoluto, il problema può iniziare a subentrare quando dal consumo
“tradizionale” di vino durante i pasti, si inizi a distaccarsi
un consumo autonomo degli alcolici. Questi, una volta svincolati dalle
ritualità del pasto, possono innestare rituali e spazi autonomi,
in cui altre modalità ed altri significati possono insinuarsi nel
loro consumo, aumentando i rischi in misura proporzionale proprio a quella
familiarità, che la nostra cultura ha con il consumo di alcol e
con una sua immagine sostanzialmente positiva o comunque non pericolosa.
Lo spostamento dalla ritualità del pasto a rituali autonomi, e
dal vino associato all'alimentazione ad altri tipi di alcolici associati
al tempo libero, una volta che si innesti in una cultura come la nostra,
in cui l'alcol non è di per sé un pericolo (come, pian piano,
lo sta invece diventando il fumo), può effettivamente produrre
dei comportamenti estremamente rischiosi. È quello che, a quanto
pare, sta accadendo nei gruppi di giovani, ed in particolare di giovani
donne, in cui, a fronte di una lenta e progressiva diminuzione generale,
il consumo di alcol sta aumentando velocemente, ed aumenta secondo rituali
che lo distaccano del cibo, lo collegano alla convivialità ma anche
alla cultura dello sballo, come abbiamo commentato in una precedente conversazione
su questo tema. E questo, a parte i rischi per l'immediato di una tendenza
all'assunzione di alcol fino a perdere il controllo di se stessi, porterà
senz'altro danni alla salute nella seconda metà della vita, ma,
se ben ricordo, a vent'anni faticavo a pensare a quando ne avrei avuto
trenta, figuriamoci oltre; e poi sorge una riflessione decisamente politically
uncorrect: non sarà che per campare, in questo mondo, qualche aiutino
è proprio indispensabile? •