
Docente di Sociologia Generale e di Sociologia dei Processi Culturali
Università di Verona

 Che
quella in cui viviamo, almeno noi occidentali, sia la società dei
consumi è ormai un luogo comune, ma qual è il significato
di questa definizione ormai quasi invecchiata? Società dei consumi
non significa soltanto che viviamo in un mondo in cui la quantità
di beni e servizi a disposizione di ciascuno di noi è la più
alta sinora conosciuta nella storia dell'umanità, ma significa
soprattutto che il mondo che ruota intorno all'acquisto ed al consumo
di merci e servizi, diviene il perno centrale sia nella vita economica
e sociale della nostra società, sia delle nostre vite individuali.
Nel modello di società che ha preceduto questo, quello basato sulla
produzione, era il tempo speso nella propria professione o nel proprio
mestiere, a dare senso e ad essere il perno della vita di ognuno, e la
ricchezza di una nazione era misurata soprattutto dalla salute del proprio
sistema produttivo e dalla quantità di beni prodotti. In una società
dei consumi, benché questi indicatori continuino ad essere usati,
è soprattutto la quantità di beni acquistati e la "fiducia
del consumatore" cioè la sua propensione a spendere, a definire
lo stato di salute del sistema economico nel suo complesso. Ma anche nella
nostra vita quotidiana, vivere in una società dei consumi ha significato
che il senso ed il peso che la nostra attività professionale aveva
nella definizione della nostra identità e nello sviluppo della
nostra personalità, si è pian piano ridotto, a favore delle
possibilità di realizzazione e di gratificazione che possiamo trovare
nel mondo del consumo, sia dal punto di vista dell'acquisto di merci e
servizi, sia dal punto di vista del loro uso. Non è più
strano incontrare persone che, nel bilancio della propria auto realizzazione,
danno un peso uguale al tipo di attività lavorativa che svolgono
ed a ciò che fanno nella sfera del consumo e del tempo libero,
ed infine, non è più così difficile trovare persone
che svalutano essenzialmente il peso simbolico della propria attività
lavorativa, usata unicamente per guadagnare denaro, ed attribuiscono il
massimo del peso e del significato, rispetto alla propria auto realizzazione,
a come spendono ciò che hanno guadagnato, a quello che fanno nel
tempo libero e nel mondo del consumo. Ma c'è un terzo significato
di società dei consumi, ed è quello che riguarda l’organizzazione
sociale del tempo e dello spazio. Da questo punto di vista, nelle nostre
società, lo spazio ed il tempo entro cui scorre la nostra vita
viene sempre più colonizzato dalle attività di acquisto
e di
Che
quella in cui viviamo, almeno noi occidentali, sia la società dei
consumi è ormai un luogo comune, ma qual è il significato
di questa definizione ormai quasi invecchiata? Società dei consumi
non significa soltanto che viviamo in un mondo in cui la quantità
di beni e servizi a disposizione di ciascuno di noi è la più
alta sinora conosciuta nella storia dell'umanità, ma significa
soprattutto che il mondo che ruota intorno all'acquisto ed al consumo
di merci e servizi, diviene il perno centrale sia nella vita economica
e sociale della nostra società, sia delle nostre vite individuali.
Nel modello di società che ha preceduto questo, quello basato sulla
produzione, era il tempo speso nella propria professione o nel proprio
mestiere, a dare senso e ad essere il perno della vita di ognuno, e la
ricchezza di una nazione era misurata soprattutto dalla salute del proprio
sistema produttivo e dalla quantità di beni prodotti. In una società
dei consumi, benché questi indicatori continuino ad essere usati,
è soprattutto la quantità di beni acquistati e la "fiducia
del consumatore" cioè la sua propensione a spendere, a definire
lo stato di salute del sistema economico nel suo complesso. Ma anche nella
nostra vita quotidiana, vivere in una società dei consumi ha significato
che il senso ed il peso che la nostra attività professionale aveva
nella definizione della nostra identità e nello sviluppo della
nostra personalità, si è pian piano ridotto, a favore delle
possibilità di realizzazione e di gratificazione che possiamo trovare
nel mondo del consumo, sia dal punto di vista dell'acquisto di merci e
servizi, sia dal punto di vista del loro uso. Non è più
strano incontrare persone che, nel bilancio della propria auto realizzazione,
danno un peso uguale al tipo di attività lavorativa che svolgono
ed a ciò che fanno nella sfera del consumo e del tempo libero,
ed infine, non è più così difficile trovare persone
che svalutano essenzialmente il peso simbolico della propria attività
lavorativa, usata unicamente per guadagnare denaro, ed attribuiscono il
massimo del peso e del significato, rispetto alla propria auto realizzazione,
a come spendono ciò che hanno guadagnato, a quello che fanno nel
tempo libero e nel mondo del consumo. Ma c'è un terzo significato
di società dei consumi, ed è quello che riguarda l’organizzazione
sociale del tempo e dello spazio. Da questo punto di vista, nelle nostre
società, lo spazio ed il tempo entro cui scorre la nostra vita
viene sempre più colonizzato dalle attività di acquisto
e di  consumo,
convertendo il tempo libero in tempo di consumo. Quando 40 o 50 anni fa,
gli scrittori "futurologi" si interrogavano su quale società
avrebbe prodotto lo sviluppo della tecnologia e l’automazione del
lavoro, espandendo verso il futuro i modelli culturali della società
in cui vivevano, ed in particolare quelli dei ceti sociali che in quella
società lavoravano meno, ritenevano che l'uomo della nostra epoca
sarebbe stato un uomo il cui tempo e la cui vita si sarebbe sviluppata
soprattutto nell'ozio e nella riflessione, in attività di tipo
artistico e comunitario, lasciando alle attività produttive poche
ore alla settimana. Anche ad un osservatore superficiale, risulta chiaro
che le cose sono andate in modo decisamente diverso. Non soltanto il tempo
dedicato al lavoro, nonostante l'infinito aumento della produttività
individuale, si è ben guardato dal diminuire, ed in alcuni casi
è addirittura aumentato, aggiungendo sistematicamente all'orario
di lavoro un lavoro straordinario che, ormai, fa stabilmente parte dell'impegno
lavorativo ordinario e normale di ciascuno di noi, ma,
consumo,
convertendo il tempo libero in tempo di consumo. Quando 40 o 50 anni fa,
gli scrittori "futurologi" si interrogavano su quale società
avrebbe prodotto lo sviluppo della tecnologia e l’automazione del
lavoro, espandendo verso il futuro i modelli culturali della società
in cui vivevano, ed in particolare quelli dei ceti sociali che in quella
società lavoravano meno, ritenevano che l'uomo della nostra epoca
sarebbe stato un uomo il cui tempo e la cui vita si sarebbe sviluppata
soprattutto nell'ozio e nella riflessione, in attività di tipo
artistico e comunitario, lasciando alle attività produttive poche
ore alla settimana. Anche ad un osservatore superficiale, risulta chiaro
che le cose sono andate in modo decisamente diverso. Non soltanto il tempo
dedicato al lavoro, nonostante l'infinito aumento della produttività
individuale, si è ben guardato dal diminuire, ed in alcuni casi
è addirittura aumentato, aggiungendo sistematicamente all'orario
di lavoro un lavoro straordinario che, ormai, fa stabilmente parte dell'impegno
lavorativo ordinario e normale di ciascuno di noi, ma,  soprattutto,
l'impiego del tempo che rimane fuori dal tempo di lavoro si è ben
guardato dall'orientarsi verso attività improduttive, di ozio,
contemplazione o socializzazione, ma si è massicciamente convertito
in un tempo altamente produttivo, che è l'esatto complemento del
tempo di lavoro, cioè il tempo di consumo. A partire dagli anni
'30 negli Stati Uniti e dal secondo dopoguerra in Europa, la pressione
dei mezzi di comunicazione per far sì che non solo il tempo libero
fosse convertito in tempo di consumo, ma che questo consumo si orientasse
in maniera acconcia ed armoniosa rispetto ai beni prodotti, è stata
continua e massiccia, e man mano che veniva meno e si de localizzava la
struttura produttiva, una quantità sempre maggiore di spazio è
stato trasformato in strutture mirate alla massimizzazione del volume
di acquisti e di consumi, con una vera e propria programmazione scientifica
di luoghi e strutture studiati a questo scopo. A partire dall'ormai vecchio
supermercato degli anni '60, sino ai nuovi centri commerciali, una continua
evoluzione di spazi, studiati per attrarre il consumatore e massimizzare
il volume di merci acquistato, ha disseminato il mondo di nuove "cattedrali
dei consumi", che sono diventate la meta abituale del tempo libero
di un numero geometricamente crescente di consumatori. Nelle cinture delle
grandi città, dove un tempo erano le fabbriche, in mezzo a quelle
che oggi sono rimaste, ma molto spesso decisamente più ampi di
queste, sono sorti e continuano a sorgere nuovi centri di attrazione,
il cui scopo è unicamente quello di attrarre i consumatori e spingerli
a restare a loro interno il maggior tempo possibile, convertendo questo
tempo in volumi crescenti di merci e servizi acquistati. Così come
nella società della produzione la fabbrica si evolve e si modifica
per ottimizzare il processo produttivo, nella società del consumo
il negozio si evolve e si modifica per ottimizzare il processo di vendita
e consumo, dando luogo ad una tipologia articolata ed in continua evoluzione
di luoghi mirati ad ottimizzare i processi di consumo, quelle che possiamo
chiamare "le cattedrali del consumo". Il primo passaggio è
quello delle catene di negozi o ristoranti che, benché indipendenti
dal punto di vista formale, devono conformarsi a criteri, parametri ed
immagine simbolica stabilite dalla "casa madre", dando luogo
ad una clonazione di strutture di
soprattutto,
l'impiego del tempo che rimane fuori dal tempo di lavoro si è ben
guardato dall'orientarsi verso attività improduttive, di ozio,
contemplazione o socializzazione, ma si è massicciamente convertito
in un tempo altamente produttivo, che è l'esatto complemento del
tempo di lavoro, cioè il tempo di consumo. A partire dagli anni
'30 negli Stati Uniti e dal secondo dopoguerra in Europa, la pressione
dei mezzi di comunicazione per far sì che non solo il tempo libero
fosse convertito in tempo di consumo, ma che questo consumo si orientasse
in maniera acconcia ed armoniosa rispetto ai beni prodotti, è stata
continua e massiccia, e man mano che veniva meno e si de localizzava la
struttura produttiva, una quantità sempre maggiore di spazio è
stato trasformato in strutture mirate alla massimizzazione del volume
di acquisti e di consumi, con una vera e propria programmazione scientifica
di luoghi e strutture studiati a questo scopo. A partire dall'ormai vecchio
supermercato degli anni '60, sino ai nuovi centri commerciali, una continua
evoluzione di spazi, studiati per attrarre il consumatore e massimizzare
il volume di merci acquistato, ha disseminato il mondo di nuove "cattedrali
dei consumi", che sono diventate la meta abituale del tempo libero
di un numero geometricamente crescente di consumatori. Nelle cinture delle
grandi città, dove un tempo erano le fabbriche, in mezzo a quelle
che oggi sono rimaste, ma molto spesso decisamente più ampi di
queste, sono sorti e continuano a sorgere nuovi centri di attrazione,
il cui scopo è unicamente quello di attrarre i consumatori e spingerli
a restare a loro interno il maggior tempo possibile, convertendo questo
tempo in volumi crescenti di merci e servizi acquistati. Così come
nella società della produzione la fabbrica si evolve e si modifica
per ottimizzare il processo produttivo, nella società del consumo
il negozio si evolve e si modifica per ottimizzare il processo di vendita
e consumo, dando luogo ad una tipologia articolata ed in continua evoluzione
di luoghi mirati ad ottimizzare i processi di consumo, quelle che possiamo
chiamare "le cattedrali del consumo". Il primo passaggio è
quello delle catene di negozi o ristoranti che, benché indipendenti
dal punto di vista formale, devono conformarsi a criteri, parametri ed
immagine simbolica stabilite dalla "casa madre", dando luogo
ad una clonazione di strutture di 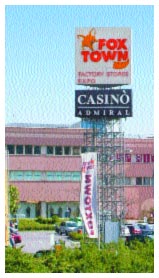 consumo
essenzialmente identiche e facilmente riconoscibili dal consumatore, si
tratta del modello del franchising, di cui la catena dei McDonald's è
sicuramente l'esempio più eclatante e diffuso ma certamente non
l'unico. Viene poi l'evoluzione dal supermercato al centro commerciale,
in cui, man mano, all'interno della struttura distributiva vengono assorbite
funzioni prima distribuite sul territorio. Si passa dalla semplice, "ingenua",
concentrazione di merci e servizi tendenzialmente omogenei in un unico
spazio, alla progettazione di uno spazio che integri merci e servizi anche
molto diversi e lontani in un’unica esperienza di acquisto, un'esperienza
che, come abbiamo più volte sottolineato in queste conversazioni,
deve divenire sempre più ludica, il famoso "shopping".
In questa chiave, accanto all'offerta di beni e servizi che, seppure in
modo molto lato, ruotano attorno al concetto di spesa e di manutenzione
domestica, l'evoluzione più probabile di queste strutture andrà
nel senso di inserire al loro interno aree che consentano al consumatore
di restarvi il più a lungo possibile, fondendo lo shopping “utile”
con altre attività di tipo più decisamente ludico, come
sta già avvenendo per i bambini. Ad esempio, inserendo all'interno
dei centri commerciali anche sale da gioco e da proiezione, costruendo
quindi un unico ambiente integrato e conchiuso, in cui tutto il tempo
speso possa essere orientato verso la maggior parte dei consumi disponibili
sul mercato, sia di acquisto che di intrattenimento, costruendo quindi
un percorso di consumo completo, del tutto indipendente dalle strutture
urbane preesistenti, una sorta di "istituzione totale” del
consumo (secondo il modello dei parchi a tema, come Disneyland) perfettamente
autonoma ed indipendente da quanto già esistente sul territorio
in cui essa si trova, studiata per poter essere replicata e clonata all'infinito
in qualsiasi società e cultura, un luogo in cui sia possibile entrare
la mattina ed uscire la sera avendo sperimentato tutti tipi di consumi
disponibili sul mercato e non altri. Una sorta di chiusura degli orizzonti
di uso del proprio tempo, che traduca definitivamente il possibile nell’esistente,
uccidendo fantasia, creatività ed immaginazione nell'uso del nostro
tempo, e trasformando, finalmente, tutto ciò che non è lavoro
in acquisto e consumo. •
consumo
essenzialmente identiche e facilmente riconoscibili dal consumatore, si
tratta del modello del franchising, di cui la catena dei McDonald's è
sicuramente l'esempio più eclatante e diffuso ma certamente non
l'unico. Viene poi l'evoluzione dal supermercato al centro commerciale,
in cui, man mano, all'interno della struttura distributiva vengono assorbite
funzioni prima distribuite sul territorio. Si passa dalla semplice, "ingenua",
concentrazione di merci e servizi tendenzialmente omogenei in un unico
spazio, alla progettazione di uno spazio che integri merci e servizi anche
molto diversi e lontani in un’unica esperienza di acquisto, un'esperienza
che, come abbiamo più volte sottolineato in queste conversazioni,
deve divenire sempre più ludica, il famoso "shopping".
In questa chiave, accanto all'offerta di beni e servizi che, seppure in
modo molto lato, ruotano attorno al concetto di spesa e di manutenzione
domestica, l'evoluzione più probabile di queste strutture andrà
nel senso di inserire al loro interno aree che consentano al consumatore
di restarvi il più a lungo possibile, fondendo lo shopping “utile”
con altre attività di tipo più decisamente ludico, come
sta già avvenendo per i bambini. Ad esempio, inserendo all'interno
dei centri commerciali anche sale da gioco e da proiezione, costruendo
quindi un unico ambiente integrato e conchiuso, in cui tutto il tempo
speso possa essere orientato verso la maggior parte dei consumi disponibili
sul mercato, sia di acquisto che di intrattenimento, costruendo quindi
un percorso di consumo completo, del tutto indipendente dalle strutture
urbane preesistenti, una sorta di "istituzione totale” del
consumo (secondo il modello dei parchi a tema, come Disneyland) perfettamente
autonoma ed indipendente da quanto già esistente sul territorio
in cui essa si trova, studiata per poter essere replicata e clonata all'infinito
in qualsiasi società e cultura, un luogo in cui sia possibile entrare
la mattina ed uscire la sera avendo sperimentato tutti tipi di consumi
disponibili sul mercato e non altri. Una sorta di chiusura degli orizzonti
di uso del proprio tempo, che traduca definitivamente il possibile nell’esistente,
uccidendo fantasia, creatività ed immaginazione nell'uso del nostro
tempo, e trasformando, finalmente, tutto ciò che non è lavoro
in acquisto e consumo. •