
Tiziano
Vecellio Salomé con la testa del Battista Roma, Galleria Doria Pamphili. |
Paolo
Calliari, detto il Veronese Madonna col Bambino e i Santi Caterina e Pietro Vicenza, Pinacoteca di Palazzo Chiericati |
El
Greco, La guarigione del cieco nato |
Battista
Franco, detto Semolei Adorazione dei pastori Milano, Collezione privata |
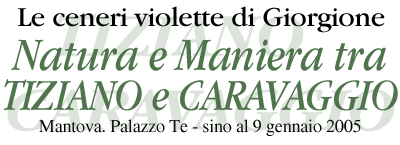
| Bonifacio
Veronese Madonna con bambino e Santi Copenhagen, Pinacoteca Nivaagard |
|
| Caravaggio Conversione di Saulo Roma, Collezione Principi Odescalchi |
|
 "La
sua arte, come quella di tutti costoro, è una sola fumata sorta
su immensa dalle ceneri violette di Giorgione, mescolatasi nella dolce
nebbia della valle padana con qualche soffio gemente di espressionismo
boreale…”. Con queste parole Roberto Longhi descrive l’opera
del pittore Dosso Dossi, e di altri rappresentanti della pittura lombarda
del Cinquecento.
"La
sua arte, come quella di tutti costoro, è una sola fumata sorta
su immensa dalle ceneri violette di Giorgione, mescolatasi nella dolce
nebbia della valle padana con qualche soffio gemente di espressionismo
boreale…”. Con queste parole Roberto Longhi descrive l’opera
del pittore Dosso Dossi, e di altri rappresentanti della pittura lombarda
del Cinquecento.
Se le tele si snodano lungo un percorso sinuoso tra l’attenzione
al dato reale e il virtuosismo formale, spesso unendo le due diverse caratteristiche,
il percorso espositivo si adegua alla fluidità di questa evoluzione.
L’iter iconografico suggerisce, secondo i più recenti studi
critici, la genesi della rivoluzionaria rappresentazione della realtà
del Caravaggio, cui partecipano nel secolo precedente molti pittori manieristi.
Il clima artistico del Cinquecento si compone di un andirivieni di affinità
e rimandi, tra manierismo e connubio paesaggio figura.
Apre la rassegna il grande Tiziano, presente in mostra con otto tele.
Tra esse due rappresentazioni delle Stimmate di San Francesco, una proveniente
da Ascoli Piceno, oggetto di restauro grazie a questo evento, pittura
di incredibile modernità in cui si riassume l’arte del Maestro. Notevoli sono i dipinti di Palma il
Vecchio, quali la Sacra Conversazione e la Flagellazione. Ancora più
degna di nota è la “Madonna col Bambino e i santi Giuseppe
e Gerolamo, adorati dal procuratore Gerolamo Marcello” opera di
un giovanissimo Tintoretto che nella straripante figura di san Gerolamo
offre un palese omaggio a Michelangelo. Tra le novità critiche
della mostra sta l’identificazione iconografica di alcune opere
di Lorenzo Lotto, operata attraverso un attento studio del libro dei conti.
riassume l’arte del Maestro. Notevoli sono i dipinti di Palma il
Vecchio, quali la Sacra Conversazione e la Flagellazione. Ancora più
degna di nota è la “Madonna col Bambino e i santi Giuseppe
e Gerolamo, adorati dal procuratore Gerolamo Marcello” opera di
un giovanissimo Tintoretto che nella straripante figura di san Gerolamo
offre un palese omaggio a Michelangelo. Tra le novità critiche
della mostra sta l’identificazione iconografica di alcune opere
di Lorenzo Lotto, operata attraverso un attento studio del libro dei conti.
 Ecco dunque
suggerito un nome per alcuni ritratti: di Giovanni Maria Pizoni, di Ludovico
Avolante. Notevole la presenza di opere di Giulio Romano, che lega il
suo nome a Palazzo Te, avendolo progettato e decorato, con uno dei massimi
capolavori della Maniera del Nord nelle sale di Psiche, dei Venti e dei
Giganti. Da non tralasciare la presenza del Correggio e del Parmigianino,
con due lezioni artistiche diverse ma parallele, così come di Dosso
Dossi, che combina il cromatismo veneto di Giorgione e Tiziano con la
compagine culturale alta e sofisticata della corte estense.
Ecco dunque
suggerito un nome per alcuni ritratti: di Giovanni Maria Pizoni, di Ludovico
Avolante. Notevole la presenza di opere di Giulio Romano, che lega il
suo nome a Palazzo Te, avendolo progettato e decorato, con uno dei massimi
capolavori della Maniera del Nord nelle sale di Psiche, dei Venti e dei
Giganti. Da non tralasciare la presenza del Correggio e del Parmigianino,
con due lezioni artistiche diverse ma parallele, così come di Dosso
Dossi, che combina il cromatismo veneto di Giorgione e Tiziano con la
compagine culturale alta e sofisticata della corte estense.
Un percorso ambizioso quello della mostra, che vuole dimostrare come nel
periodo del Manierismo nel nord Italia, in particolare nella Valle Padana,
fosse sorta una scuola pittorica che nulla aveva da invidiare a quella
di Raffaello e di Michelangelo.
Una mostra segnata da una italianissima querelle tra gli organizzatori
ed il Ministero dei Beni Culturali circa l'enorme tavola del Caravaggio,
"La Conversione di Saulo", prestata dalla Principessa Odescalchi,
assicurata per 50 milioni di euro e “bloccata” dal veto dei
Soprintendenti del Ministero, su cui si è scagliato con la ben
nota veemenza Vittorio Sgarbi.
Nonostante l’incidente, l'iter pittorico appare completo al visitatore,
confermando l'importanza della città di Mantova come centro di
manifestazioni culturali ed artistiche di rilevanza non solo nazionale,
accanto ad altre città (Ferrara, Parma,…); in un'ideale rinascita
di un polo artistico padano erede di una grande tradizione, che si affianca
alle tradizionali città d'arte italiane. •
 |
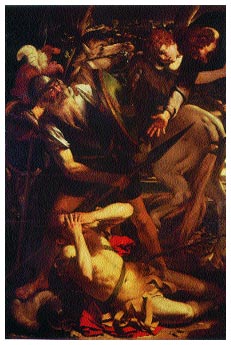 |
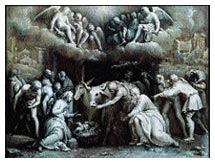 |