
Docente di Sociologia Generale e di Sociologia dei Processi Culturali
Università di Verona

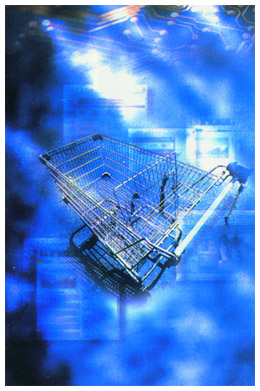 Sono
ormai passati molti anni da quando la nascita della rete planetaria, poi
chiamata Internet, aveva fatto battere il cuore a molti idealisti, che
vedevano in questo nuovo, enorme, strumento di comunicazione un’epocale
possibilità di rilanciare la democrazia partecipata e dal basso.
Con la creazione del cyberspazio si veniva a costituire, concretamente,
quell’utopia di comunicare direttamente tutti con tutti che, dai
tempi dell’agorà ateniese è rimasta, nella mente di
noi occidentali, come l'età dell'oro della libertà e della
democrazia. Non a caso, in questi primi anni, vi fu tutto un fiorire di
comunità virtuali, città e piazze virtuali, con l'intento
di allargare a macchia d'olio l'interscambio orizzontale tra i partecipanti
alla rete, in alternativa, utopica alternativa, allo scadimento che le
potenzialità partecipative delle democrazie occidentali, stavano
mostrando con l'avvento delle multinazionali, con la concentrazione del
potere e con le manipolazioni mediatiche di cittadini ormai ridotti a
"masse" di utenti, di ascoltatori, di consumatori, ma mai di
cittadini. Si trattò di una stagione tanto affascinante quanto
breve, e proprio pochi mesi fa, abbiamo salutato il fallimento dell'ultima
di quelle iniziative ancora rimasta in piedi, la famosa "città
invisibile", che per anni aveva cercato di costruire un punto di
incontro e di scambio tra i cybernauti. Ma si potrebbe dire che, se queste
iniziative che tentavano di trasportare nello spazio comunicativo di Internet
quelle che erano le vecchie strutture partecipative della democrazia ideale
sono, infine, fallite, non è domo lo spirito di indipendenza, libertà
e partecipazione che le animava.
Sono
ormai passati molti anni da quando la nascita della rete planetaria, poi
chiamata Internet, aveva fatto battere il cuore a molti idealisti, che
vedevano in questo nuovo, enorme, strumento di comunicazione un’epocale
possibilità di rilanciare la democrazia partecipata e dal basso.
Con la creazione del cyberspazio si veniva a costituire, concretamente,
quell’utopia di comunicare direttamente tutti con tutti che, dai
tempi dell’agorà ateniese è rimasta, nella mente di
noi occidentali, come l'età dell'oro della libertà e della
democrazia. Non a caso, in questi primi anni, vi fu tutto un fiorire di
comunità virtuali, città e piazze virtuali, con l'intento
di allargare a macchia d'olio l'interscambio orizzontale tra i partecipanti
alla rete, in alternativa, utopica alternativa, allo scadimento che le
potenzialità partecipative delle democrazie occidentali, stavano
mostrando con l'avvento delle multinazionali, con la concentrazione del
potere e con le manipolazioni mediatiche di cittadini ormai ridotti a
"masse" di utenti, di ascoltatori, di consumatori, ma mai di
cittadini. Si trattò di una stagione tanto affascinante quanto
breve, e proprio pochi mesi fa, abbiamo salutato il fallimento dell'ultima
di quelle iniziative ancora rimasta in piedi, la famosa "città
invisibile", che per anni aveva cercato di costruire un punto di
incontro e di scambio tra i cybernauti. Ma si potrebbe dire che, se queste
iniziative che tentavano di trasportare nello spazio comunicativo di Internet
quelle che erano le vecchie strutture partecipative della democrazia ideale
sono, infine, fallite, non è domo lo spirito di indipendenza, libertà
e partecipazione che le animava.

Come spesso accade, il nuovo strumento di comunicazione porta quelle spinte
che, in altre situazioni, si erano canalizzate in determinate strutture,
come ad esempio la piazza, a prendere altre forme, a coniugare diversamente
il proprio potenziale. È quello che è accaduto con Internet.
La spinta libertaria e partecipativa che questo grande spazio comunicativo
permetteva di concretizzare, anziché prendere la strada della vecchia
agorà ateniese si è sviluppata nel senso dello scambio e
del dono. Nonostante i ripetuti tentativi di criminalizzare questa propensione
al dono, che ha informato le strutture di scambio che si sono generate
sulla rete, come i cosiddetti peer-to-peer (attività stimata, come
partecipanti attivi, in circa il 17% delle persone connesse, soprattutto
sotto i 25 anni o al di sopra dei 55), mettendole in grado di potersi
attivare nel rispetto del diritto d'autore, anziché utilizzare
strategie di intimidazione - per via legale perseguendo, sperando nel
famoso adagio "colpiscine uno, educane cento", alcuni casi ed
ignorando invece la domanda sociale che promanava dall'uso e dalla diffusione
di questi scambi, oppure per via informatica diffondendo virus e siti-civetta,
per colpire gli utilizzatori di queste strutture di scambio - nonostante
tutto questo, dicevo, lo spirito di scambio, di dono e di indipendenza
insito nella rete delle reti continua a vivere. Ed a vivere, ad esempio,
nella statistica diffusa, qualche tempo fa, da un’organizzazione
americana che ha monitorato l'uso sociale di Internet. Questa organizzazione
(pewinternet.org), attraverso le proprie indagini, afferma che addirittura
il 44% degli americani connessi alla rete, contribuisce in qualche modo
a produrre il materiale (informazioni, testi, foto, files, siti web ecc.)
che fluisce su Internet, generando propri contenuti ed offrendoli all'uso
pubblico. Il 44%, nei comportamenti sociali, è una cifra enorme,
significa quasi uno su due, equivale, praticamente, a dire "tutti".
Tra questi, la maggior parte, quasi il 20%, contribuisce soprattutto scambiando
files con altri utenti, essenzialmente per il desiderio di condividerli
e donarli, vista l'impossibilità di pensare ad un meccanismo che
possa permettere la rendicontazione ed il pagamento di un numero così
elevato e frammentato di scambi. Altro dato interessante, il 10% ha inviato
commenti e messaggi a newsgroup, i famosi gruppi di discussione, una delle
risorse più antiche e meno pubblicizzate della rete, in cui gli
utenti interagiscono tra loro e si scambiano informazioni senza passare
dai siti, le vetrine del web, che costituiscono l’aspetto più
noto, più pubblicizzato e più attraente, ma meno partecipativo
ed interattivo della rete. Se vogliamo usare l’analogia urbana,
i newsgroup sono i bar ed i siti le vetrine. Ancora una volta, è
la rete che ci offre un segnale chiaro di come in futuro sia necessario
abbandonare le tecnologie della comunicazione di massa, nonché
la mentalità autoritaria che ad essa si associa, e come, anche
dal punto di vista economico, lo sviluppo indichi la strada della facilitazione
della comunicazione "dal basso", e non quella dell’imposizione
vertice-periferia, tipica delle strutture di massa come la televisione
o i sistemi di distribuzione delle merci. Se il discorso può sembrare
vago, si pensi alla diffusione dei telefonini, nati come status symbol
per manager impegnati e per sostenere strategiche comunicazioni aziendali,
sviluppatisi poi come mercato di massa, come strumenti di socializzazione
orizzontale e di comunicazione tra pari, sostenendo le reti affettive
ed amicali con un flusso costante di "chiacchiere" o, più
recentemente, di messaggi scritti che, si noti, costituiscono ormai più
del 10% del fatturato dei vari operatori telefonici. Le strategie basate
sul controllo attraverso strumenti di comunicazione intimidatori ed autoritari,
di masse di clienti da gestire come un proprio patrimonio, cui vendere
ciò che si ritiene più vantaggioso, è sicuramente
una strategia non soltanto vecchia ma destinata al fallimento, come dimostra
anche l'infinito braccio di ferro tra le reti di scambio su Internet e
le case discografiche, ostinate ad intimidire la propria clientela anziché
offrirle ciò che essa richiede. Questa fusione tra Internet e la
logica del dono e della condivisione, è sicuramente una linea molto
interessante di contatto attraverso le macchine telematiche, un contatto
che riscalda quella comunicazione che, altrimenti, le macchine rischiano
di sterilizzare, ed è forse una delle strade per sviluppare nuove
socialità e nuovi rapporti umani, in una post modernità
che vedrà sempre di più le persone nomadi tra lavori, affetti,
città, quindi bisognose di mani lunghe che si tengano comunque
intrecciate, anche attraverso le macchine telematiche. •