
Autoritratto, 1927-28 olio su tela. |
Fantasia 1942 ca, olio su tela |
Case
al Foro Traiano 1930, olio su tela |
Piazza
Mignanelli 1942, olio su tela |

| Demolizioni
in via Gallia 1936, olio su tela |
|
Natura
morta con fiori 1942, olio su tela |
|
Tramonto
sul Lungotevere 1929, olio su compensato |
|
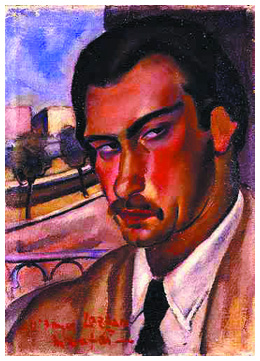 "Ho
vissuto la natura come la vivono gli uccelli. Gli alberi, le case, le
vie, gli insetti, tutto era bello, si trasformavano entro di me nel loro
seme di bellezza e di vita”. Con queste parole, Mario Mafai descriveva
la propria idea d’arte.
"Ho
vissuto la natura come la vivono gli uccelli. Gli alberi, le case, le
vie, gli insetti, tutto era bello, si trasformavano entro di me nel loro
seme di bellezza e di vita”. Con queste parole, Mario Mafai descriveva
la propria idea d’arte.
Nel quarantesimo anniversario della scomparsa del pittore, avvenuta nel
’65, molte le iniziative che celebrano uno dei massimi protagonisti
dell’arte italiana fra le due guerre, tra cui la mostra bresciana
che segue quella splendida di Palazzo Venezia, a Roma.
Oltre trenta opere, scelte da Marco Goldin e Fabrizio D’Amico, permettono
al visitatore di ripercorrere, attraverso quadri di valore assoluto, l’intero
arco dell’esperienza artistica di Mafai.
Dal sodalizio con Scipione e Antonietta Raphael ebbe origine la “Scuola
di Via Cavour”, una definizione che si deve al critico Roberto Longhi
il quale, nel 1929, segnalava il carattere espressionista delle ricerche
del terzetto come una delle più interessanti novità nel
contesto romano, opposta al formalismo arcaizzante e monumentale dell'arte
del tempo.
Ed era a Via Cavour la casa in cui Mafai abitava con la sua compagna,
Antonietta Raphael, dalla quale ebbe le tre figlie Miriam, Simona e Giulia:
quella stessa casa che il pittore vide demolire nel ventennio fascista
per far spazio alla nuova Via dell’Impero.
Mafai andrà letto non solo nel segno di questo gruppo che sostanzialmente
identifica un 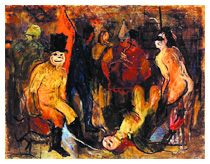 sodalizio
umano, più che una vera e propria corrente, ma soprattutto per
aver tradotto con linguaggio nuovo ansie e turbamenti che sono stati sì
di tutta un’epoca, tra le più tragiche della nostra storia,
ma che per lui hanno avuto prima di tutto valenza esistenziale.
sodalizio
umano, più che una vera e propria corrente, ma soprattutto per
aver tradotto con linguaggio nuovo ansie e turbamenti che sono stati sì
di tutta un’epoca, tra le più tragiche della nostra storia,
ma che per lui hanno avuto prima di tutto valenza esistenziale.
Senza dunque concedersi completamente al realismo sociale, la sua pittura,
che per molto tempo fu venata di un espressionismo discreto, liricamente
doloroso, seppe tradurre, per tragiche Fantasie, i drammi del tempo.
Dopo il periodo più intenso della Scuola di Via Cavour, conclusosi
drammaticamente con la morte di Scipione nel 1933, per Mafai prosegue
con i dipinti dedicati ai fiori, che denotano la scelta di motivi intimi
e dimessi, e poi con le 'demolizioni', documento degli interventi urbanistici
del fascismo, fino al dramma della guerra.
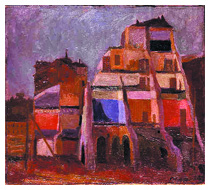 Nel 1939
Mafai si trasferisce con la famiglia a Genova, per sottrarre Antonietta
alle discriminazioni razziali. Ai primi anni Quaranta risale la serie
Fantasia, un insieme di dipinti ispirati alle drammatiche esperienze
di quegli anni e chiaramente influenzati dalle 'pitture nere' di Goya
e dall'espressionismo nordico.
Nel 1939
Mafai si trasferisce con la famiglia a Genova, per sottrarre Antonietta
alle discriminazioni razziali. Ai primi anni Quaranta risale la serie
Fantasia, un insieme di dipinti ispirati alle drammatiche esperienze
di quegli anni e chiaramente influenzati dalle 'pitture nere' di Goya
e dall'espressionismo nordico.
Da Ungaretti a de Libero, da Sinisgalli, a Beccaria, a Falqui, furono
molti gli uomini di cultura che intrattennero con lui proficui rapporti
d’amicizia e di lavoro
Il dopoguerra vede Mafai attraversare un breve periodo neorealista, come
mostra l'Osteria di Via Flaminia, mentre a partire dalla fine
degli anni Cinquanta si orienta verso l'informale e la pittura materica:
abbandona il riferimento stretto alla realtà sostituendolo con
pure tessiture cromatiche, fino alla serie delle Corde.
Un tema rimane costante nella sua produzione, ed è la città
di Roma: Mafai ha evocato l’Urbe nell'intero arco della sua carriera,
rappresentandone gli scorci più suggestivi, i mutamenti, le ferite
provocate dagli interventi demolitori, il dramma della guerra, fino ai
paesaggi dell'ultimo periodo, come il Tramonto sull'Appia Antica,
quando ormai si era avviato all'astrattismo.
In realtà, quella che la critica ha definito la fase astratta della
sua opera, altro non è se non un processo che i titoli delle sue
ultime opere ben sintetizzano: alla fine bisogna Cancellare la memoria
(1959) e dipingere solo Ciò che rimane (1960), ovvero
la Solitudine (1961). •
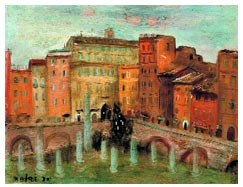 |
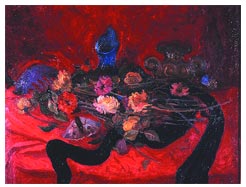 |
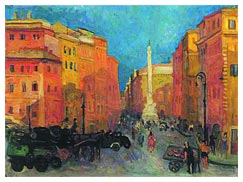 |
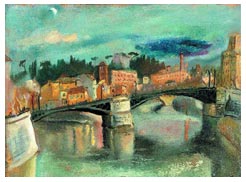 |