
Docente di Sociologia Generale e di Sociologia dei Processi Culturali
Università di Verona
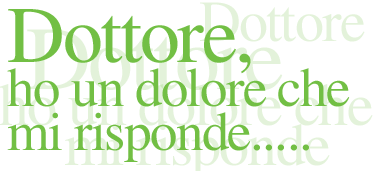
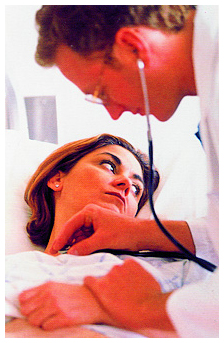 Sin
da quando ero piccolo, i malanni di mia madre e delle mie zie non erano
malesseri isolati, malattie, ma erano delle vere e proprie epopee, cori
o assemblee di dolori e fastidi che, ben lungi dal presentarsi isolati
all'appello, interagivano ed interloquivano gli uni con gli altri dando
luogo a scambi e sentieri che attraversavano in vario modo i corpi e i
tempi del malato. Queste complesse mappe risiedevano, per essere disegnate
ed attraversate, lunghi tempi di conversazione che riempivano spesso gli
spazi lasciati liberi dalle attività domestiche delle mie zie che
confrontandosi tra loro e narrandosi le varie evoluzioni dei propri malanni,
si aiutavano anche reciprocamente a comprendere meglio quali potevano
essere i messaggi e di significati nascosti in questi contrappunti che
attraversavano il loro corpo. Quasi sempre nel racconto delle reciproche
le relazioni e di reciprocità punti di contatto dei vari dolori,
si nascondeva la rappresentazione di problemi un pochino più ampi
e complessi che trovavano nei reciproci contatti tra i vari dolori, una
grammatica simbolica attraverso cui esprimersi, che egli ha pian piano
dipanata nel racconto reciproco.
Sin
da quando ero piccolo, i malanni di mia madre e delle mie zie non erano
malesseri isolati, malattie, ma erano delle vere e proprie epopee, cori
o assemblee di dolori e fastidi che, ben lungi dal presentarsi isolati
all'appello, interagivano ed interloquivano gli uni con gli altri dando
luogo a scambi e sentieri che attraversavano in vario modo i corpi e i
tempi del malato. Queste complesse mappe risiedevano, per essere disegnate
ed attraversate, lunghi tempi di conversazione che riempivano spesso gli
spazi lasciati liberi dalle attività domestiche delle mie zie che
confrontandosi tra loro e narrandosi le varie evoluzioni dei propri malanni,
si aiutavano anche reciprocamente a comprendere meglio quali potevano
essere i messaggi e di significati nascosti in questi contrappunti che
attraversavano il loro corpo. Quasi sempre nel racconto delle reciproche
le relazioni e di reciprocità punti di contatto dei vari dolori,
si nascondeva la rappresentazione di problemi un pochino più ampi
e complessi che trovavano nei reciproci contatti tra i vari dolori, una
grammatica simbolica attraverso cui esprimersi, che egli ha pian piano
dipanata nel racconto reciproco.
E anche un modo per mettere in comune la propria vita e i propri affanni,
che venivano espressi anche attraverso la mediazione di significato simbolico
che i vari ho che i e i rapporti, dolorosi, che si avevano l'un l'altro
potevano esprimere. Era sicuramente importante la condivisione, il fatto
che la trama delle relazioni tra i vari acciacchi fosse condivisa anzi,
costruita insieme perché in questo modo deriva costruita, insieme,
anche il senso e di significato biografico che questa mappa voleva esprimere.
Ritrovare non soltanto dei dolori simili, ma anche delle relazioni tra
dolori simili significava ritrovarsi in di testi di vita, spesso faticosa
o spiacevole, comune e quindi condividerli. Il racconto condiviso della
malattia e del suo dispiegarsi il tutto un coro di richiami che legavano
insieme le varie parti del corpo, era essenziale nella condivisione è
nell'appoggio che dal gruppo poteva venire al malato o alla sofferente,
ed aveva proprio lo scopo di sollecitare comprensione e condivisione,
più che consigli risolutori. Le soluzioni, infatti, spesso avrebbero
reso necessario un cambiamento della propria vita, ed erano quindi impraticabili,
ciò che si desiderava era la comprensione e la condivisione, il
sostegno, e di racconto reciproco e condiviso esercitare esattamente questa
funzione. Ben vengano quindi i consigli di lenimenti, attività
varie volte a limitare il fastidio ed il dolore, in quanto forme, in fondo,
di condivisione e di mutuo aiuto, ma assolutamente pericolosi i consigli
risolutori, orientati ad eliminare alla radice la fonte del malessere,
molto spesso legata ad una relazione o ad un’attività che
deriva svolta nell'ambito del proprio ruolo sociale, questo avrebbe significato
rifiutare quel legame di condivisione e di accettazione del malessere
seppure all'interno di un mutuo aiuto, avrebbe significato rifiutare l'identificazione
che veniva richiesta, e quindi avrebbe dovuto esso stesso significato
di un rifiuto dell'aiuto che veniva richiesto, aiuto che non era volto
alla soluzione del problema e quindi la scomparsa della polifonia di malesseri,
bensì alla condivisione e alla reciproca identificazione come "sofferenti".
Va da sé che anche le mie zie sapevano benissimo che eliminando
alcuni obblighi sociali o alcune relazioni faticose avrebbero eliminato
anche i loro malanni, ma non era questo che volevano, realtà volevano
essere accettate, considerate proprio per quel sacrificio cui si sottoponevano,
e di rituale di racconto dei malanni era proprio uno dei modi per assicurarsi
questa considerazione.
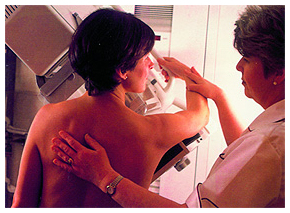 Proporre
loro di risolvere il problema alla radice significava non dare importanza
a quell'attività che esse si sobbarcavano e quindi, infine, al
loro ruolo ed alla loro attività nella piccola comunità
in cui vivevano. Infatti, molto spesso il malanno o anche la malattia
diviene un momento fondamentale in cui si cerca la comunicazione dell'importanza
e della considerazione che abbiamo nel nostro ambiente, oppure, diviene
un modo per entrare in una relazione con gli altri secondo un modello
che hanno piace, come accadeva per le mie figlie nel racconto dei loro
malanni, che le caratterizzava immediatamente come attive, indispensabili,
votata sacrificio dei beni di aiuto e compassione. L'importanza sociale
del sacrificio si rifletteva esattamente nell'obbligo di ascoltare il
racconto dei loro malanni, ma ben più importante era la funzione
di reciproco racconto come condivisione e senso di appartenenza al gruppo
delle donne della famiglia con i loro vissuti, con i loro doveri, con
i loro malanni. Guai volerli guarire completamente, si sottraeva un pezzo
della loro identità e del loro modo di presentarsi al mondo e metterlo,
in qualche modo, in posizione debitoria.
Proporre
loro di risolvere il problema alla radice significava non dare importanza
a quell'attività che esse si sobbarcavano e quindi, infine, al
loro ruolo ed alla loro attività nella piccola comunità
in cui vivevano. Infatti, molto spesso il malanno o anche la malattia
diviene un momento fondamentale in cui si cerca la comunicazione dell'importanza
e della considerazione che abbiamo nel nostro ambiente, oppure, diviene
un modo per entrare in una relazione con gli altri secondo un modello
che hanno piace, come accadeva per le mie figlie nel racconto dei loro
malanni, che le caratterizzava immediatamente come attive, indispensabili,
votata sacrificio dei beni di aiuto e compassione. L'importanza sociale
del sacrificio si rifletteva esattamente nell'obbligo di ascoltare il
racconto dei loro malanni, ma ben più importante era la funzione
di reciproco racconto come condivisione e senso di appartenenza al gruppo
delle donne della famiglia con i loro vissuti, con i loro doveri, con
i loro malanni. Guai volerli guarire completamente, si sottraeva un pezzo
della loro identità e del loro modo di presentarsi al mondo e metterlo,
in qualche modo, in posizione debitoria.
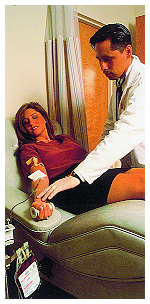 Anche il
vecchio medico di famiglia si era adattato a questo rituale, e mentre
riproponeva alle mie zie i soliti medicamenti che, ritualmente, riproponeva
ad ogni racconto, ascoltava pazientemente i vari percorsi dei vari malessere
all'interno del corpo, e le voci che questi malanni si lanciavano l'un
l'altro da un organo all'altro. Il tutto, naturalmente, condito con i
tradizionali riferimenti o ai cibi ingeriti o alle fasi stagionali se
non quotidiane del tempo. Un vero e proprio racconto cosmogonico in cui
i vari organi, il corpo e la natura interagivano l'uno con l’altro
scambiandosi messaggi e significati. Particolarmente interessante ruolo
dei dolori e malessere, che non venivano visti tanto come messaggi lanciati
dei vari organi verso l'esterno, ma come funzioni più complesse
di tutto il corpo, esseri quasi autonomi che nel loro peregrinare per
il corpo o nella loro comunicazione con altri malanni o dolori, costituivano
un testo, un messaggio complessivo, che andava decodificato nella sua
unitarietà per capire cosa il corpo stava mandando a dire. Quello
che si tesseva era un dialogo con il proprio corpo che vedeva i vari dolori
e malessere come autonomi messaggeri, capaci di colloquiare anche tra
loro, oppure di spostarsi da un organo all'altro raccogliendo informazioni
diverse, ed indicando, proprio con il loro spostamento, legami e parentele
che il malato doveva attentamente decodificare. Il corpo dolorante di
veniva un testo, un racconto, il richiamo tra i vari malesseri costruiva
la trama per leggerlo e comprenderne il significato nascosto.
Anche il
vecchio medico di famiglia si era adattato a questo rituale, e mentre
riproponeva alle mie zie i soliti medicamenti che, ritualmente, riproponeva
ad ogni racconto, ascoltava pazientemente i vari percorsi dei vari malessere
all'interno del corpo, e le voci che questi malanni si lanciavano l'un
l'altro da un organo all'altro. Il tutto, naturalmente, condito con i
tradizionali riferimenti o ai cibi ingeriti o alle fasi stagionali se
non quotidiane del tempo. Un vero e proprio racconto cosmogonico in cui
i vari organi, il corpo e la natura interagivano l'uno con l’altro
scambiandosi messaggi e significati. Particolarmente interessante ruolo
dei dolori e malessere, che non venivano visti tanto come messaggi lanciati
dei vari organi verso l'esterno, ma come funzioni più complesse
di tutto il corpo, esseri quasi autonomi che nel loro peregrinare per
il corpo o nella loro comunicazione con altri malanni o dolori, costituivano
un testo, un messaggio complessivo, che andava decodificato nella sua
unitarietà per capire cosa il corpo stava mandando a dire. Quello
che si tesseva era un dialogo con il proprio corpo che vedeva i vari dolori
e malessere come autonomi messaggeri, capaci di colloquiare anche tra
loro, oppure di spostarsi da un organo all'altro raccogliendo informazioni
diverse, ed indicando, proprio con il loro spostamento, legami e parentele
che il malato doveva attentamente decodificare. Il corpo dolorante di
veniva un testo, un racconto, il richiamo tra i vari malesseri costruiva
la trama per leggerlo e comprenderne il significato nascosto.
La medicina accreditata nella nostra società, che ha nella chirurgia
da un lato e nel farmaco dall'altro i suoi pilastri, non ha certo più
tempo di ascoltare questi dialoghi silenziosi, ha raggiunto i livelli
di efficienza che la caratterizzano smontando il corpo ed occupandosi
di frammenti via via più minuti, ma essenziali, del suo funzionamento,
come ad esempio le cellule, i batteri, il virus; anche la chirurgia, per
poter raggiungere i livelli di efficacia che ha raggiunto, ha dovuto via
via focalizzarsi su elementi sempre più circoscritti, è,
comunque, credo che la chirurgia, per sua natura, sia comunque quella
con l'orecchio più duro rispetto ai silenziosi colloqui di cui
stiamo parlando. Avrebbe dovuto essere sicuramente la medicina, ed in
particolare quella generale, a recuperare questo tipo di dimensione del
malessere, anziché diventare anch'essa sorda, traducendo il malessere
in apparati di malattia interfacciati con sistemi di diagnostica strumentale
e di farmaci che, spesso, riducono al nulla il colloquio tra medico e
paziente. Non a caso, come abbiamo più volte detto in queste conversazioni,
è proprio in questa dimensione narrativa ed, anzi, auto-narrativa,
che si è inserito, almeno sino ad ora, l'orecchio delle medicine
alternative, ancora attente alla visione olistica e complessiva del paziente
prima che del suo malessere, e al testo simbolico che egli, attraverso
i suoi malanni, cerca di costruire e comunicare al mondo. •