
 |
 |
DI DOCUMENTI AZIENDALI
È LEGITTIMA SE NECESSARIA ALL’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI DIFESA.
Lavoro in banca da circa dieci anni ed ho sempre avuto ottimi rapporti con i colleghi e con i superiori (...). A seguito di una recente riorganizzazione aziendale sono stato trasferito per “soppressione dell’ufficio” a cui ero addetto. Tale modifica, a quanto mi risulta, esiste solo “sulla carta”, giacché al mio posto è stato collocato un altro dipendente che svolge le mie identiche mansioni; per provare tale situazione dovrei produrre in giudizio alcune lettere e fax comprovanti la prosecuzione dell’attività lavorativa del mio ex ufficio anche dopo il mio trasferimento. È lecito fare ciò, oppure rischio il licenziamento?
(lettera firmata)
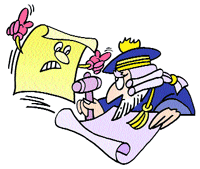 La
questione della legittimità o meno della produzione in giudizio
dei documenti aziendali ha dato luogo ad un ampio dibattito dottrinale
e giurisprudenziale senza approdare, al momento, ad un risultato sicuro
ed univoco.
La
questione della legittimità o meno della produzione in giudizio
dei documenti aziendali ha dato luogo ad un ampio dibattito dottrinale
e giurisprudenziale senza approdare, al momento, ad un risultato sicuro
ed univoco.
Un primo e più risalente orientamento ha ravvisato l’illegittimità
di siffatto comportamento (v. Cass., 25 ottobre 2001, n. 13188; Cass.,
2 marzo 1993, n. 2560; e, nel merito, Trib. Milano, 31 ottobre 1997, in
Lavoro giur., 1998, 591; Pret. Vicenza, 2 giugno 1995 in Notiziario giurisprudenza
lav., 1995, 605; Trib. Lodi, 16 marzo 1982 in Orient. giur. lav., 1982,
1280) per la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di riservatezza,
con inevitabile lesione dell’elemento fiduciario (art. 2105 c.c.)
e conseguente facoltà datoriale di irrogare la sanzione del licenziamento;
una tesi intermedia ha invece ammesso che la produzione in giudizio di
fotocopie di documenti aziendali riservati fosse un inadempimento più
lieve rispetto a quello della sottrazione di documenti, non potendo da
ciò discendere la liceità del licenziamento per l’evidente
sproporzione fra il fatto contestato e la gravità della sanzione
(Cass., 2 febbraio 2000, n. 1144; Cass., 9 maggio 1996, n. 4328); infine,
un più recente orientamento si è spinto a conclusioni più
radicali, dichiarando la liceità della produzione di documentazione
aziendale, essendo questo, per il lavoratore, un mezzo per tutelare i
propri diritti e, quindi, rappresentando una esigenza prevalente rispetto
a quella di riservatezza del datore di lavoro (v. in tal senso Cass.,
7 luglio 2004, n. 12528; Cass., 4 maggio 2002, n. 6420).
Venendo al quesito proposto, si segnala che una recentissima sentenza
di Cassazione (Cass. 7 dicembre 2004 n. 22923), occupandosi di un caso
analogo, ha confermato la facoltà del lavoratore di suffragare
la domanda giudiziale attraverso la produzione delle fotocopie di alcuni
documenti aziendali, ritenendo illegittime le ragioni del datore di lavoro
che per tale motivo lo aveva licenziato, addebitandogli di aver violato
i doveri di riservatezza e correttezza.
Tale tesi è stata giustificata dal Supremo Collegio con la prevalenza
del diritto alla difesa rispetto alle esigenze di segretezza di dati in
possesso del datore di lavoro, tanto più che la stessa normativa
in tema di privacy non richiede il consenso dell’interessato nell’ipotesi
in cui il trattamento sia necessario “per far valere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento”.
Si segnala, ad ogni modo, che la giurisprudenza predilige – ai fini
della legittimità del comportamento – che la produzione riguardi
documenti fotocopiati (e non sottratti) dei quali il lavoratore sia venuto
in possesso in modo lecito, rientrando (possibilmente) questi ultimi,
direttamente o indirettamente, nella sua disponibilità.
In conclusione, a fronte di tale recente orientamento pare doversi escludere
il rischio di licenziamento per la produzione in giudizio di fotocopie
documenti aziendali da parte del lavoratore, sempre che queste siano state
reperite in modo lecito. Ciononostante si suggerisce, ancora, di usare
prudenza, essendo semmai preferibile – a fronte dell’ondivaga
situazione giurisprudenziale – seguire la strada, meno rischiosa,
di far disporre dal giudice il deposito della documentazione da parte
del datore di lavoro (art. 210 c.p.c). •
CHI SI ATTIENE AD UNA PRASSI
INTERNA
DIFFORME DAL REGOLAMENTO AZIENDALE
NON COMMETTE INFRAZIONE DISCIPLINARE
Cassazione, Sezione Lavoro, 16 agosto 2004, n. 15950.
È illegittima la sanzione disciplinare della censura irrogata ad
un impiegato di banca per aver consentito a un correntista il superamento
del limite di affidamento senza richiedere l’autorizzazione della
direzione nei modi previsti dal regolamento, in quanto, secondo la prassi
costantemente seguita dalla banca, similari comportamenti assunti in precedenza
dal lavoratore non avevano mai dato adito a rilievi, neppure verbali,
rafforzando, quindi, nell’interessato il convincimento della loro
legittimità.
 La
sentenza affronta l’interessante problema dei comportamenti del
lavoratore conformi alla prassi, ma difformi dal regolamento aziendale,
pervenendo alla condivisibile conclusione che i medesimi devono considerarsi
legittimi, presumendosi l’accettazione implicita della modifica
regolamentare per facta concludentia in caso di mancata opposizione da
parte del datore di lavoro.
La
sentenza affronta l’interessante problema dei comportamenti del
lavoratore conformi alla prassi, ma difformi dal regolamento aziendale,
pervenendo alla condivisibile conclusione che i medesimi devono considerarsi
legittimi, presumendosi l’accettazione implicita della modifica
regolamentare per facta concludentia in caso di mancata opposizione da
parte del datore di lavoro.
Nella specie, ad un dipendente del Banco di Napoli era stata irrogata
la sanzione della censura per aver consentito ad un correntista il superamento
del limite di affidamento senza richiedere a mezzo fax o per posta, come
previsto dal regolamento, l’autorizzazione della direzione. Il lavoratore
aveva sostenuto in giudizio di avere chiesto ed ottenuto l’autorizzazione
allo sconfinamento per telefono, attenendosi ad una prassi interna, mentre
la Banca si era difesa sostenendo l’irrilevanza di una prassi contraria
al regolamento.
La Suprema Corte ha accolto le ragioni del lavoratore, ritenendo ingiustificato
l’addebito disciplinare basato sulla violazione di regole procedimentali,
essendo stata provata l’esistenza di una prassi diversa, non contrastata
e quindi accettata dalla banca. La Corte, oltretutto, non ha ritenuto
rilevante ai fini del decidere la mancata prova della tolleranza di tale
prassi da parte della banca, essendo stato invece provato il fatto che
nessuna iniziativa per “elidere” la medesima era mai stata
adottata.
Per impedire la formazione della prassi, è bene notare, occorre
che il datore di lavoro assuma una posizione di fermo diniego, giacché,
secondo la giurisprudenza (Cass., 7 aprile 1998, n. 3591), qualora l’istituto
bancario non prenda una posizione chiara su determinati tipi di operazioni
che, in un contesto di prassi, (sotto molto aspetti lontane dai principi
di correttezza, trasparenza e legalità), vengono tollerate da parte
dei dirigenti della banca, non è possibile muovere addebiti ai
singoli dipendenti in relazione alle operazioni stesse, presumendosi anche
in questo caso l’accettazione tacita dei comportamenti da parte
del datore di lavoro. •