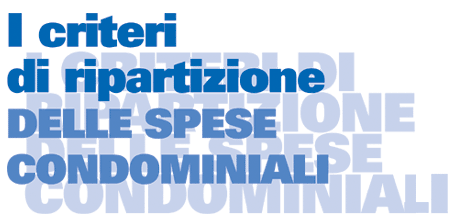
 In
un fabbricato composto da più appartamenti, uffici e negozi di cui
siano proprietari svariati soggetti, quindi in condominio, non vi è
modo migliore per rappresentare le singole quote che quello della percentuale.
Per comodità di frazionamento e per conseguente disposto del codice
civile l’espressione avviene nel nostro sistema in millesimi.
In
un fabbricato composto da più appartamenti, uffici e negozi di cui
siano proprietari svariati soggetti, quindi in condominio, non vi è
modo migliore per rappresentare le singole quote che quello della percentuale.
Per comodità di frazionamento e per conseguente disposto del codice
civile l’espressione avviene nel nostro sistema in millesimi.
E’ da chiedersi in primo luogo chi sia il soggetto legittimato a definire l’attribuzione originaria dei millesimi ai singoli immobili, attribuzione che dovrà essere man mano accettata dai diversi nuovi proprietari. Normalmente l’originario unico proprietario dell’intero fabbricato, in pratica spesso il costruttore, definisce la ripartizione in tabelle millesimali anteriormente all’alienazione del primo appartamento, atto quest’ultimo da cui consegue, come abbiamo detto in precedenti occasioni, l’automatica costituzione del condominio
Questa ripartizione viene quindi inserita dal costruttore nel regolamento così detto contrattuale (anche di esso abbiamo parlato), cui dovranno aderire appunto i successivi acquirenti delle singole porzioni di fabbricato. Ogni modifica successiva di questo regolamento, e quindi anche delle tabelle condominiali, richiederà in generale l’assenso di tutti i condomini, fermo restando tuttavia che le tabelle non possono certo avere un valore assoluto ed immodificabile. Infatti i singoli, di fronte ad evidenti errori o a necessità dovute a modifiche dell’edificio potranno, in caso di mancato accordo da parte di tutti i condomini, ottenere la ridefinizione delle tabelle facendo ricorso all’autorità giudiziaria.
 Naturalmente
la quota di millesimi di proprietà, che è la fonte base
per la ripartizione delle spese, non può essere a sua volta considerata,
anche se accettata, un criterio assoluto e valido per tutte le spese,
giacché in questo ambito devono essere considerati aspetti peculiari
di ogni unità immobiliare, ad esempio il livello di piano, l’autonomia
dell’ingresso (poniamo di un negozio) rispetto all’androne
comune, ovvero l’assenza di collegamento con l’impianto di
riscaldamento centralizzato.
Naturalmente
la quota di millesimi di proprietà, che è la fonte base
per la ripartizione delle spese, non può essere a sua volta considerata,
anche se accettata, un criterio assoluto e valido per tutte le spese,
giacché in questo ambito devono essere considerati aspetti peculiari
di ogni unità immobiliare, ad esempio il livello di piano, l’autonomia
dell’ingresso (poniamo di un negozio) rispetto all’androne
comune, ovvero l’assenza di collegamento con l’impianto di
riscaldamento centralizzato.
Il regolamento contrattuale ha ampie possibilità di definizione
in merito, ma per alcune spese particolari già il codice civile
definisce criteri speciali e la giurisprudenza (cioè l’orientamento
dei tribunali e delle corti) ha adattato ai tempi tali criteri. Ad esempio
il codice civile ha stabilito che le spese di manutenzione e rifacimento
delle scale sono sostenute “dai proprietari dei diversi piani a
cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà
in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra
metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo”.
Essendo il codice stato emanato nel 1942, manca un riferimento esplicito
agli ascensori, che in effetti a quel tempo erano una rarità. Ebbene,
la giurisprudenza, per l’evidente analogia con le scale, ha stabilito
che lo stesso criterio vada seguito per la ripartizione delle spese relative
all’ascensore, salvo diversa previsione del regolamento.
Il codice prevede anche una regola generale, art. 1123, secondo cui “[I]. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione [II]. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. [III]. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Come si vede, in questa previsione si tratta di principi molto generali, che ad una lettura superficiale non dicono molto ed in effetti possono dare luogo a dubbi interpretativi. Non è questa una carenza, diciamo così, professionale del legislatore, ma un’astrattezza imposta dal fatto che nonostante quanto si possa credere un buon ordinamento giuridico deve tendere ad evitare la sovrabbondanza di norme scritte, sopra tutto quelle di dettaglio. Infatti è dimostrato che il pur teoricamente encomiabile tentativo di riuscire a prevedere e disciplinare tutto quello che nella società avviene, producendo molte norme, si traduce sempre ed invariabilmente nel caos delle leggi, difficili da conoscere e sopra tutto in frequente contraddizione fra di esse. Vi sono infatti ordinamenti giuridici, come quelli anglo americani e prima ancora di diritto romano, ove le norme scritte sono ridotte al minimo, ma nei quali la certezza delle regole e la rapidità di applicazione sono notevoli (certo va detto che in quegli ordinamenti il ruolo della giurisprudenza, vale a dire le sentenze delle corti stratificatesi nel tempo, è notevolissimo).
 Tornando alla
nostra generale previsione di codice, dobbiamo considerare comunque che
altri articoli disciplinanti la comunione ed il condominio, nonché
alcune leggi speciali, hanno cercato di dare dettagliata normazione ai
casi più importanti, ed ora ne vedremo alcuni (che si aggiungono
a quello delle scale già visto).
Tornando alla
nostra generale previsione di codice, dobbiamo considerare comunque che
altri articoli disciplinanti la comunione ed il condominio, nonché
alcune leggi speciali, hanno cercato di dare dettagliata normazione ai
casi più importanti, ed ora ne vedremo alcuni (che si aggiungono
a quello delle scale già visto).
Ancora, circa l’art. 1123 diremo anche che degno di nota è
il terzo comma sopra riportato, in quanto è quello che conferisce
legittimità alla così detta “ripartizione per scale”
di alcune spese che gli amministratori spesso fanno nei bilanci sottoposti
all’assemblea.
Quando ad esempio la spesa di riparazione di una colonna di scarico viene divisa fra gli appartamenti che quella colonna serve, o quando ad esempio i condomini di una certa scala decidono di rifare l’ascensore in autonomia (anche di spesa) non siamo di fronte a “pericolose” disgregazioni del condominio o a tentativi dell’amministratore di applicare il noto principio dei Romani “divide et impera”, bensì siamo di fronte all’applicazione, spesso con mero buon senso, del principio di legge generale di cui abbiamo ora detto.
Alcune regole specifiche di ripartizione delle spese riguardano poi le
soffitte, le volte, i solai e le terrazze. L’art.1125 prevede che
“le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario
del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario
del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
Si tratta evidentemente di norme che hanno inteso disciplinare con buon
senso le peculiari situazioni dei fabbricati in cui normalmente la comunione
è limitata solo ad alcuni dei condomini.
Per le terrazze, che fanno da tetto per tutto il fabbricato o parte di
esso e che sono in uso esclusivo o di proprietà di singoli (il
codice le definisce tecnicamente “lastrici solari di uso esclusivo”)
è stabilito che quando l'uso dei lastrici solari o di una parte
di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso
esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni
o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti
i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare
serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno.
In questo caso la norma tende a salvaguardare la posizione di tutti, considerato
che “chi sta sopra” ha pur sempre un vantaggio notevole dalla
copertura, usata ad esempio come giardino pensile, ma che per altro verso
è indispensabile per “chi sta sotto”, dando naturalmente
protezione dalle infiltrazioni meteoriche. A questi ultimi condomini (cui
tuttavia si aggiunge di nuovo il titolare del terrazzo quale condomino
al pari degli altri) la legge attribuisce i 2/3 della spesa, anche sul
presupposto che quelli “che stanno sotto” sono in pratica
i, molti, proprietari degli appartamenti che in colonna sono situati sotto
la terrazza. Quindi i 2/3 attribuiti a tutti in realtà di solito
si riducono in quote individuali abbastanza limitate, grazie appunto alla
molteplicità dei condomini.
Tuttavia l’edilizia, sopra tutto quella più recente, ha visto il fiorire di stabili dalle caratteristiche più articolate rispetto ai tradizionali fabbricati che oggi alcuni architetti chiamano “in linea” (i grandi parallelepipedi che conosciamo con molti appartamenti sovrapposti a colonne). Oggi si rinvengono molte situazioni condominiali in case “a schiera”, “a spina”, bi-tri e quadri familiari, dallo sviluppo in verticale molto articolato. Ecco quindi che in alcuni casi “chi sta sotto” può essere un unico malcapitato, che in base all’articolo di codice in esame deve sorbirsi gran parte della spesa praticamente da solo. Ed ecco allora un altro caso specifico in cui magari si vorrebbe una norma particolare. Ma appunto, come dicevamo prima, il legislatore non ci ha pensato e pur tuttavia, se lo avesse fatto, o cercasse di farlo sempre, avremmo l’inconveniente di cui si parlava: una congerie di moltissime norme scritte fra le quali sarebbe ancor più difficile orientarsi e che finirebbero inevitabilmente per contraddirsi a vicenda.
.