
Docente di Sociologia Generale e di Sociologia
dei Processi Culturali Università di Verona

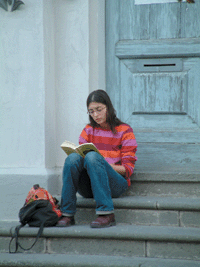 se
volessimo individuare un oggetto che possa simboleggiare in maniera alta
la nostra civiltà occidentale, esso è sicuramente il libro.
se
volessimo individuare un oggetto che possa simboleggiare in maniera alta
la nostra civiltà occidentale, esso è sicuramente il libro.
A partire dai pochi libri dei filosofi greci, scritti a mano, su carta
preziosa, da leggere tendenzialmente ad alta voce, come se ci si confrontasse
direttamente ed alla presenza di tutti con l'autore, sino ad arrivare
ai libri virtuali, digitalizzati, che però stentano ad imporsi
all'uso ed all'immaginario collettivo sostituendo i vecchi ed amati volumi
di carta più o meno preziosa, ma con l'inconfondibile profilo a
mattonella, veri "mattoni" del sapere.
L'analogia con il mattone, e la costruzione è del resto trasparente
nella simbologia che ruota attorno al libro, non a caso i testi più
impegnativi e fondanti delle varie discipline, ma in particolare delle
discipline classiche come la storia e la filosofia, sono a tutti gli effetti
mattoni, sia nel senso di elementi indispensabili della costruzione, in
questo caso del sapere, sia nel senso di pesanti e massicci bocconi, tanto
fondanti quanto di difficile digestione.
Del resto non sarà un caso se le tre religioni che hanno contribuito,
in vario modo, alla costruzione della modernità occidentale: quella
ebraica, quella cristiana e quella islamica, sono dette "del libro"
in quanto si riconoscono tutte, più o meno, nell'antico testamento,
ed hanno comunque alla loro radice un libro, mattone fondativo e guida
indiscussa del proprio dogma.
Ma il libro non è soltanto simbolo dell'antichità, del sapere
dei saggi cristallizzato, contenuto e protetto nei libri come in un prezioso
giacimento; questo fa parte, dal nostro punto di vista, della storia antica
del libro quella, per intenderci, del manoscritto di pergamena, copiato
a costo di lunghe ore di lavoro dai monaci e gelosamente custodito nei
conventi del medioevo.
Già in questa fase, però, comincia a rivelarsi un altro
dei caratteri fondamentali del libro, anche questo parte del suo essere
simbolo della nostra civiltà, il suo essere un cristallizzato del
pensiero, della conoscenza, del messaggio che qualcuno ha voluto affidargli.
Va da sé che, qualora questo messaggio risultasse sgradito al potere
o a qualcuno che possa prendere decisioni e porre in essere azioni importanti,
non soltanto dovrà essere eliminata la fonte di quel messaggio,
intesa come persona, ma anche tutti quegli oggetti che quel messaggio
contengono e possono diffondere, innanzi tutto i libri.
La distruzione dei libri costituisce, nell'ambito della sua simbologia,
la parte nera e nascosta del suo significato. Se il libro ci parla di
conoscenza, sapienza, crescita ed indipendenza intellettuale, la sua distruzione
non può parlarci altro che di oscurantismo, sudditanza e dittatura,
sui fatti e sulle idee. Talmente forte è il radicamento del significato
simbolico del libro nella nostra cultura e civiltà, che la sua
distruzione, anche ai tempi nostri in cui i libri vengono prodotti in
migliaia ed a volte milioni di copie, provoca imbarazzo e riprovazione,
come se si trattasse di un sacrilegio o dell’infrazione di un importante
tabù. Provate a dire ai vostri amici o a proporre di distruggere,
magari bruciandolo per esagerare nella simbologia, un libro, che magari
avete in due o anche tre copie e non rileggerete mai più in tutta
la vostra vita, vedrete serpeggiare imbarazzo e riprovazione, come se
si proponesse di violare un radicato e consolidato tabù, questa
è la forza simbolica del libro, di qualsiasi libro, nella nostra
cultura e civiltà. Per noi, infatti, il libro non è più
soltanto il simbolo del sapere, della sua accumulazione e della sua sacralità
come fondamento della nostra civiltà, ma è anche il simbolo
della libertà individuale, della libertà di pensiero nel
poter accedere, liberamente, a questo sterminato giacimento di sapere,
di pensieri, di opinioni che nei secoli si sono adagiati sulle pagine
dei libri. Questo aspetto della complicata architettura di significati
che costituiscono questo importantissimo oggetto-simbolo, si lega ad un
altro simbolo fortissimo della nostra civiltà: il concetto di individuo
e della sua libertà. 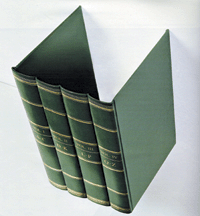
Il libro che noi conosciamo, quello prodotto in serie dall'industria tipografica,
rappresenta tuttora ed ha rappresentato per secoli uno dei più
efficaci mezzi di diffusione delle idee, da cui la necessità, per
i poteri assoluti, di controllarlo. Ed ha rappresentato anche il mezzo
più potente per mettere in relazione ciascun individuo con il patrimonio
di conoscenza e di idee dell'umanità, ciascun individuo singolarmente
senza più la mediazione dei sapienti che traducevano le varie verità
per coloro che non potevano accedere direttamente ad esse.
Secondo diversi studiosi, la rivoluzione della riforma luterana, fu in
larga parte favorita dalla disponibilità di bibbie che si era venuta
a creare grazie alla tecnologia della stampa a caratteri mobili, che permise
ad una fascia di persone prima inconcepibile di leggere direttamente ed
individualmente gli scritti biblici. In questo modo ciascuno poteva instaurare,
attraverso il proprio libro, un dialogo individuale con la conoscenza
contenuta nel libro stesso, con grandi filosofi e pensatori del passato
e del presente, con il grande vantaggio di poter trarre da questo dialogo
privato una altrettanto privata e libera, opinione, combinando quindi
liberamente il messaggio affidato al libro con la propria particolare
disposizione nel leggerlo e nell'applicarne il contenuto alla realtà.
In questa chiave, il libro e l'individuo si sviluppano di pari passo come
una coppia inscindibile che produce quella libertà del pensiero
e della coscienza che è uno dei più alti prodotti della
nostra civilizzazione.
La lettura individuale del libro, a differenza di quella collettiva dell'antichità,
che stimolava soprattutto l'udito e creava un forte senso di gruppo e
di affidamento all'autorità che leggeva il libro, stimola invece
una dimensione di concentrazione e silenzio individuale, un pensiero interno
che assorbe e colloquia incessantemente con i contenuti del libro, che
stimola soprattutto la vista e crea un atteggiamento di valutazione soggettiva
e di concentrazione individuale che distaccano la persona dal mondo tribale
ed emotivo dell'orecchio, per consegnarla a quello individuale e razionale
della vista. Una condizione che i media elettronici, come la televisione,
hanno poi ulteriormente modificato.
E’ molto difficile, infatti, leggere un libro in un contesto collettivo
e men che meno in un contesto dominato dai suoni, la stessa necessità
di concentrazione per decodificare i segni grafici e ricostruire il pensiero
contenuto nel libro, rende indispensabile il silenzio e la concentrazione
individuale.
Questa necessità oggettiva separa anche nei comportamenti minuti
e quotidiani, le persone dai contesti collettivi e dall'enfasi emotivo-tribale
dell'orecchio, allontanandola dalla fusione col gruppo. Potremmo quasi
dire, esagerando un po', che esiste un confine abbastanza forte, rispetto
alla dipendenza dal gruppo ed all'autonomia individuale, tra chi è
abituato a leggere e chi è abituato a parlare.
Se cerchiamo quindi
un simbolo complessivo
della nostra civilizzazione, molto probabilmente l'immagine dell'individuo
solo, assorto nella lettura del proprio libro è certamente una
delle migliori.