
 |
 |
LO SPOSTAMENTO, PER MOTIVI DISCIPLINARI,
A MANSIONI DIVERSE (E PER DI PIŁ INFERIORI)
COSTITUISCE PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO
Sono un dipendente bancario e fino a pochi mesi fa mi occupavo della “Gestione Portafoglio Clienti”, ruolo che ho ricoperto per più di dieci anni. A seguito di un provvedimento disciplinare che, oltretutto, ha coinvolto anche altri Colleghi mi sono state assegnate mansioni diverse, per lo più di contenuto generico, ripetitivo e del tutto prive della benché minima responsabilità. In tale frangente sono stato oltretutto spostato dalla Filiale alla Direzione (....). Mi sento leso non soltanto nella professionalità ma anche nei rapporti con la clientela, con i Colleghi (...). Alla luce di quanto esposto, vorrei sapere come poter tutelare al meglio la mia posizione.
(lettera firmata)
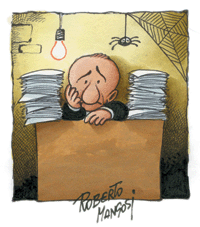 Il
problema – che presenta due nodi critici fondamentali – va
esaminato alla luce della disciplina legislativa e della giurisprudenza
sullo jus variandi e sul potere disciplinare del datore di lavoro.
Il
problema – che presenta due nodi critici fondamentali – va
esaminato alla luce della disciplina legislativa e della giurisprudenza
sullo jus variandi e sul potere disciplinare del datore di lavoro.
Riguardo al primo aspetto, occorre ricordare, come peraltro più
volte detto nel corso di questa rubrica, che l’art. 2103 c.c. sancisce
l’obbligo di adibire il prestatore di lavoro “(...) alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte”. Secondo il nostro ordinamento,
dunque, il datore di lavoro, nel modificare le mansioni del dipendente,
deve rispettare la professionalità di quest’ultimo anche
con riferimento all’esperienza maturata nel corso del rapporto.
La giurisprudenza prevalente ha poi affermato che “devono considerarsi
inferiori quelle mansioni che, rispetto alle precedenti, comportino una
sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore”
(v. Cass., n. 7789/1993; Cass., n. 4561/1995; Cass., 14666/2004) ed è
soltanto un orientamento minoritario quello che, per la modifica delle
mansioni, consente di far leva su una capacità professionale potenziale
del lavoratore, suscettibile di sviluppi anche in direzioni sostanzialmente
diverse rispetto al bagaglio di nozioni acquisite (v. in tal senso Cass.,
n. 5098/1985; Cass., n. 9584/1990; Cass., n. 276/1995).
Quale conferma dell’orientamento prevalente sopra evidenziato, v’è
poi quella giurisprudenza che impedisce l’adibizione del lavoratore
a mansioni che, pur inquadrate nel medesimo livello contrattuale, richiedono
però l’applicazione di conoscenze non rispondenti alla specifica
competenza del prestatore e alla professionalità da questo maturata,
tanto da non garantire allo stesso un arricchimento del proprio patrimonio
di esperienze (in tal senso v., di recente, Cass. n. 13187/2005, che in
un caso analogo a quello ora esposto ha ribadito la necessità di
“accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza
del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale
acquisito e da garantire lo svolgimento e l’accrescimento delle
sue capacità professionali”).
Con riferimento all’altro aspetto sopra evidenziato, v’è
da rilevare che l’art. 7, comma 4º , st. lav. (l. n. 300/1970),
nel sancire il divieto di irrogare sanzioni che comportino mutamenti definitivi
del rapporto di lavoro, vieta in sostanza gli spostamenti e/o la retrocessione
di mansioni, adottata a titolo di sanzione.
In tale prospettiva, qualora il lavoratore possa dimostrare che lo spostamento
a mansioni diverse, peraltro meno gratificanti da un punto di vista umano
e professionale, sia stato disposto unicamente per motivi disciplinari
sarà possibile invocare l’illegittimità del provvedimento
per contrasto con l’art. 7 st. lav. (a tal riguardo v. recentemente
Cass., n. 13187/2005; Cass., n. 11520/1997; Cass., n. 5797/1991; nel merito,
v. Pret. Milano, 19.01.1989).
Venendo al caso di specie, dunque, il richiedente – ove sussistano
i presupposti sopra evidenziati – potrà eventualmente tutelarsi,
impugnando la modifica delle mansioni sia sotto il profilo della carenza
dell’equivalenza professionale, sia sotto il profilo della connotazione
disciplinare del provvedimento.
SULL’OBBLIGO DELL’
INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO
IN CASO DI MALATTIA INSORTA ALL’ESTERO
CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, 24
GIUGNO 2005, N. 13622
La regola di cui all’art. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito
in legge 29 febbraio 1980 n. 33, la quale impone al lavoratore l’obbligo
di recapitare o trasmettere al datore di lavoro, entro due giorni dal
relativo rilascio, il certificato di diagnosi e l’attestazione sull’inizio
e la durata della malattia, nonché quello di indicare il domicilio
durante la malattia stessa, è applicabile, in base ai principi
di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c. c., anche all’ipotesi
di malattia contratta all’estero.
 Nota
Nota
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione affronta l’interessante
questione relativa all’invio della certificazione medica di malattia
al datore di lavoro qualora il dipendente abbia contratto la malattia
all’estero.
Pur ribadendo l’assoluta mancanza di una specifica normativa in
argomento, il Supremo Collegio, sulla base di principi generali di correttezza
e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), ritiene che anche nell’ipotesi
di malattia contratta all’estero, vi sia l’obbligo del dipendente,
(ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980),
di inviare al datore di lavoro per raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico attestante la malattia, nonché quello di
indicare – per finalità di controllo – il proprio domicilio
durante la stessa.
La sentenza tuttavia non specifica alcunché circa le modalità
attraverso cui il lavoratore deve procurarsi il certificato medico.
A tale proposito l’INPS ha emanato delle precise disposizioni (v.
circolare n. 11 del 14 settembre 1990 e n. 136 del 25 luglio 2003), differenziando
il comportamento da tenere in caso di malattia insorta in Paesi stranieri
convenzionati con l’Italia o membri dell’Unione Europea e
quella verificatasi in Paesi terzi.
Per quanto concerne i primi due Paesi il lavoratore deve rivolgersi all’istituzione
sanitaria estera competente a disposizione del quale il lavoratore dovrà
mettersi in caso di malattia; quest’ultima provvederà poi
a trasmettere all’INPS la certificazione medica acquisita; mentre
il lavoratore dovrà comunque documentare al proprio datore di lavoro,
entro due giorni dalla data di rilascio del certificato, il suo stato
di malattia.
Con riferimento invece ai Paesi stranieri che non hanno stipulato con
l’Italia Convenzioni o Accordi specifici che regolano la materia,
l’interessato deve far pervenire all’INPS e al datore di lavoro,
entro due giorni dal rilascio, la certificazione medica originale appositamente
legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana
operante nel territorio estero.
Sulla base della sentenza in commento, nonché delle disposizioni
INPS sopra evidenziate, si prospetta un quadro assai complesso di adempimenti
in capo al lavoratore che si ammali all’estero. Seppure discutibile,
la regola dell’invio del certificato medico dovrebbe applicarsi
– alla stregua dei principi di correttezza e buona fede di cui sopra
– anche ai dipendenti delle aziende del credito, nonostante il loro
trattamento di malattia non sia indennizzato dall’INPS; mentre,
l’iter descritto dall’ente previdenziale per ottenere la certificazione
medica idonea dovrebbe essere ritenuto necessario soltanto in caso di
malattia di esclusiva competenza dell’INPS.